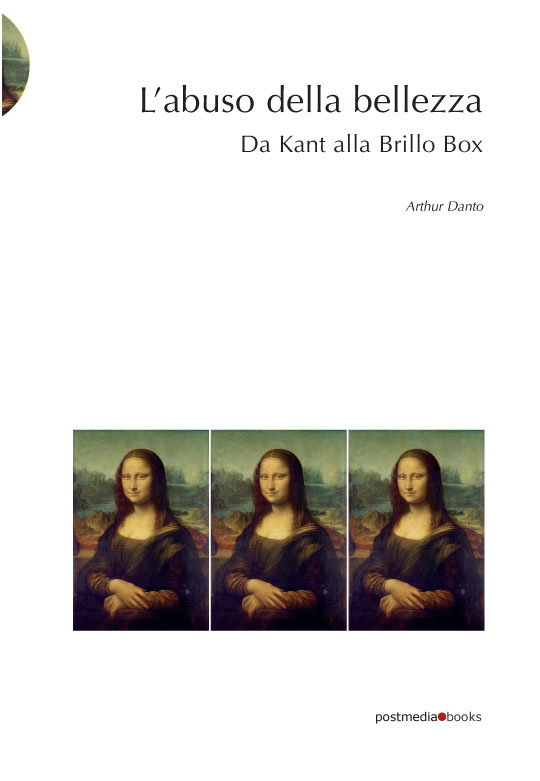
|
Marco E. Giacomelli / Exibart / 17-apr-2008
L’occhio ha una storia oppure è solo la rappresentazione che cambia nel tempo? La bellezza è una categoria obsoleta oppure può ancora essere utile per leggere l’arte contemporanea? Meglio Kant oppure Hegel? Le risposte di un gigante americano della filosofia dell’arte, Arthur C. Danto. Recentemente riscoperto dagli editori italiani (...).
Ha un tenore simile, colloquiale, il volume edito da Postmedia, L’abuso della bellezza, essendo la rielaborazione di tre Carus Lecture tenute nel 2001. L’andamento argomentativo miscela aneddoti e cenni biografici, mentre quasi di soppiatto operano “le lunghe pinze della filosofia analitica”. Arthur C. Danto - L'abuso della bellezzaChe innanzitutto separano l’estetica kantiana e il suo presunto concetto-chiave, la bellezza, dalla filosofia dell’arte (non tout court, ma quella elaborata da Danto a partire dalla dilagante influenza di temi hegeliani). Ciò non significa che la bellezza sia da espungere dal dominio dell’arte, come ha fatto l’“avanguardia intrattabile”, bensì comporta la sua relativizzazione -anche se è assai probabile che a Danto non piacerebbe questo termine- nel quadro di una pluralità di qualità estetiche o “flessori”, dal disgusto al sublime. E tuttavia, la bellezza di Danto conserva ancora un carattere eccezionale ed edwardiano, poiché “è l’unica qualità estetica ad essere anche un valore”. L’impressione è che si torni, senza passare dal via, alla trinità nemmanco tanto laica costituita da verità, bontà e beltà.
Giuseppe Patella / L'Unità / 23-feb-2008
Dalla scatola al quadro: le trasfigurazioni della bellezza
Tutto comincia con la famosa Fountain. Siamo nel 1917 e Marcel Duchamp cerca di far accettare un orinatoio come opera d’arte per l’esposizione annuale dell’americana Society of Indipendent Artists. L’opera viene rifiutata, ma nel giro di pochi anni diventa talmente famosa da restare per sempre come simbolo del nuovo che scuote il campo dell’arte moderna. È l’inizio di quella rivoluzione concettuale che muterà per sempre lo scenario dell’arte del Novecento. Il gesto di Duchamp viene poi ripreso e reso ancora più popolare negli anni sessanta da Andy Warhol, che con i suoi famosi Brillo Box, ad esempio, che non sono altro che delle scatole di spugnette abrasive usate per pulire le stoviglie, rende praticamente impossibile distinguere l’oggetto artistico dall’oggetto quotidiano.
Ed è proprio sul significato di questi gesti artistici, la cui portata è evidentemente tutta di natura teorica, che il filosofo americano Arthur C. Danto ha da sempre cercato di riflettere nei suoi lavori, la maggior parte dei quali sono però perlopiù sconosciuti al pubblico italiano.
L’uscita imminente del suo libro L’abuso della bellezza. Da Kant alla Brillo Box (Milano, Postmedia, pagine 192, euro 21,00) rappresenta quindi una buona occasione per conoscere meglio questo acuto pensatore e per fare seriamente i conti con questi e altri grandi problemi che l’arte contemporanea pone. Questo libro, che rappresenta l’ultimo volume di una ideale trilogia che raccoglie la sua filosofia dell’arte cominciata con The Transfiguration of the Commonplace (1981) e continuata con After the End of Art (1997), è dedicato in particolare al tema della bellezza, al suo declino nell’età delle avanguardie artistiche, in cui arte e bellezza un tempo associate si separano definitivamente, ma anche alla sua eterna e attuale rinascita in forme diverse, talvolta paradossali, sconvolgenti o addirittura disgustose.
In tutti questi testi, come nei suoi molti altri saggi dedicati all’arte, Danto osserva attentamente il panorama artistico contemporaneo,che dopo le rivoluzioni di Duchamp e di Warhol è popolato sempre più da oggetti strani, talmente «strani» da essere però del tutto «familiari» (scolabottiglie, orinatoi, detersivi, sedie, letti, animali, manichini, ecc.), e si pone sempre le stesse domande fondamentali: cosa fa di un oggetto comune un’opera d’arte? Dove sta la differenza tra l’opera e l’oggetto? Chi decide dell’eventuale artisticità dell’oggetto ordinario? E la risposta di Danto, semplice ma efficace, è sostanzialmente sempre la stessa: l’oggetto comune è come «trasfigurato» in un’opera d’arte, e questa trasfigurazione è possibile solo sulla base di un determinato sviluppo storico e artistico (il che vuol dire, ad esempio, che le opere di Warhol non sarebbero state possibili e non sarebbero state comprese in un periodo storico diverso dal suo). E poi non c’è alcuna differenza reale, cioè sensibile, percettiva, tra le scatole di Brillo che troviamo al supermercato e quelle di Warhol esposte nei musei, la differenza è piuttosto di natura teorica, concettuale, sta - scriveva Danto già nel 1964 - in una certa «atmosfera di teoria artistica», in una conoscenza della storia dell’arte, in un «mondo dell’arte» (Artworld).
Ma se nell’atmosfera di totale libertà dell’arte contemporanea tutto può essere arte, perché non c’è più una «narrazione storica progressiva», allora significa che viviamo nell’era dell’arte «post-storica». E se attraverso la crescente consapevolezza di sé l’arte oggi è diventata sempre più filosofia, questo ha significato anche la «fine dell’arte» (the End of Art), è in sintesi la tesi hegeliana di Danto.
Aldo Marroni / Traduttologia / estate 2008
Arthur Coleman Danto (1924) è considerato il padre dell’estetica analitica, linea di pensiero su cui pesa l’interrogativo più arduo intorno allo statuto dell’arte. La domanda fondamentale per gli analitici, non è più intorno al che cosa e qual è l’essenza dell’opera d’arte, ma, quando un qualsiasi oggetto prelevato dalla vita quotidiana può assumere il valore simbolico di un fatto artistico cui sono attribuite delle qualità anche di natura estetica. Nelson Goodman nel volume I linguaggi dell’arte (1968), aveva sostenuto, partendo da una posizione nominalistica, che dietro ai simboli c’è sempre un mondo che dà loro esistenza e forma, così come avviene per un oggetto la cui elevazione e costituzione ad opera d’arte dipenderebbe da un atto consapevolmente intenzionale.
Intorno al pensiero di Danto, la cui formazione si pone a cavallo tra l’esperienza artistica e filosofica europea e quella americana (appunto analitica) sta crescendo in Italia un notevole interesse. Infatti nel 2008, oltre a L’abuso della bellezza (ed. orig. 2003), terzo volume di una significativa trilogia, sono apparse in traduzione italiana anche le altre due opere della triade, vale a dire The Transfiguration of commonplace, 1981 (La trasfigurazione del banale, Bari, Laterza), After the End of Art, 1997 (Dopo la fine dell’arte, Milano, Bruno Mondadori), cui si è aggiunta la raccolta di saggi The Philosophical Disenfranchisement of Art, 1986 (La destituzione filosofica dell’arte, Palermo, Aesthetica). E’ praticamente a disposizione dello studioso italiano la produzione più importante del filosofo americano. Il che porta a riflettere su un dato sicuramente positivo, ovvero l’apertura della nostra cultura estetica, dominata prima dalla visione crociana e poi da quella hegelo-marxista, alla riflessione di pensatori la cui tradizione filosofica ha ben altre radici, quella del pragmatismo, da cui è notoriamente espunto ogni interrogativo sull’essenza e l’origine dell’opera d’arte che tanta parte ha avuto nel pensiero continentale (cito Heidegger e l’origine dell’opera d’arte, per tutti).
Il titolo del libro mette uno accanto all’altro aspetti della storia dell’estetica che, così posti, assumono un senso quasi irriverente. Perché il riferimento alla bellezza dovrebbe essere letto sotto l’accezione negativa di un abuso? In fondo più bellezza c’è nel mondo più speranze si possono nutrire, se è vero che solo la bellezza salverà il mondo. Ma questo è solo un aspetto presente nel titolo. La linea di congiunzione che porterebbe dal giudizio di gusto proposto da Kant alla Brillo Box appare ancor più irrispettosa e incomprensibile. Cosa ha a che fare il filosofo della Critica della facoltà di giudizio (1790), con la provocazione di Andy Warhol? Apparentemente nulla, salvo tirarlo dentro la problematica dell’arte contemporanea solo per ottenere un effetto di superamento della stessa nozione di gusto.
A cambiare la vita artistica e filosofica di Danto è l’incontro nel 1964 proprio con la Brillo Box, una scatola in cui sono contenute delle pagliette di alluminio, riprodotta in una dimensione maggiore, copiata da Warhol direttamente da quelle messe in vendita in un qualsiasi supermercato newyorchese. Alla base degli interrogativi che egli si pone vi è una sottolineatura di carattere storico (non bisogna dimenticare che Danto nasce come filosofo della storia, inclinazione testimoniata dall’opera Filosofia analitica della storia, pubblicata nel 1965, tradotta in Italia da Il Mulino nel 1971): “Agli inizi – scrive – mi ponevo la seguente questione filosofica: com’era possibile che qualcosa diventasse opera d’arte in un dato momento storico, specie quando non poteva aver avuto quello status in precedenza” (p.13). Questa considerazione sembra essere un perfetto calco della teoria che Heinrich Wölfflin espone nella sua opera più importante e influente I concetti fondamentali della storia dell’arte (1915): “ogni artista si trova di fronte a determinate possibilità ottiche a cui è vincolato. Non tutto è possibile in ogni tempo”. Il tempo della Brillo Box è il 1964, quando ormai l’arte aveva detto tutto quello poteva dire e, secondo Danto, si avviava sulla strada di una competizione senza esclusione di colpi con la filosofia, assumendo su di sé, con la sperimentazione concettuale, l’onere di una riflessione sul proprio modo di essere e di operare. L’arte diventa l’interrogativo sull’arte, processo autoriflessivo di una pratica speciale.
Una continuo ed incontrollabile processo di osmosi e di transiti avvia la riflessione sull’arte verso un ulteriore obiettivo: il riconoscimento che la filosofia non può esercitare più nessun dominio sulla creazione artistica attraverso l’estetica e soprattutto surdeterminando il ruolo della bellezza. La Brillo Box introduce all’enigma delle “coppie indiscernibili”, dell’impossibilità di distinguere il mondo degli oggetti dal mondo dell’arte. Warhol ha scoperto che nulla più lega il bello all’arte, legittimando il brutto, il disgustoso e il banale entro una costellazione riservata classicamente e storicamente ai prodotti dello spirito. Il divorzio è compiuto e l’estetica (nella quale Danto riesce a vedere soltanto l’apoteosi filosofica del bello, dimenticando la radice etimologica della stessa parola estetica) può essere liquidata come una disciplina desueta della filosofia (giudizio espresso anche da Adorno, con accenti ancor più critici, nella sua postuma Teoria estetica). Liquidazione avviata da Marcel Duchamp già nel 1917 con la sacralizzazione artistica dell’orinatoio. Il filosofo americano trascrive un tagliente pensiero di Barnett Newman: “L’estetica è per l’arte quello che l’ornitologia è per gli uccelli”. Partendo da questo giudizio netto, Danto approfondisce il senso critico ed esclusivo del suo punto di vista: “La concezione filosofica dell’estetica era quasi interamente dominata dall’idea di bellezza, specie nel Settecento […] Tuttavia la bellezza quasi scompare nel Novecento […] appariva vuota dal punto di vista cognitivo e questo confermò l’inutilità dell’estetica in quanto disciplina che aveva fatto troppo affidamento sulla bellezza” (p.30). Anche Paul O. Kristeller nel suo classico saggio Il sistema moderno delle arti (1951-52), sostiene che è il Settecento ad inaugurare il concetto di beaux-arts e quindi il matrimonio tra il bello e l’arte. Viene, tuttavia, da chiedersi se il superamento di questa visione unitaria delle arti faticosamente conquistata nel XVIII secolo, nel contesto dell’arte contemporanea, in cui la produzione creativa ha espunto ogni riferimento al piacevole e assunto il disgusto quale suo centro ispiratore, significhi disfarsi una volta per tutte dell’estetica o, piuttosto, non vi si debba leggere l’invito ad una sua riformulazione sotto l’egida dell’estetico, inteso come ammirazione per tutto ciò che esalta il sentire. Danto con una sorta di capriola filosofica, pur continuando a sostenere l’equazione estetica=teoria del bello, paradossalmente fa sua la filosofia dell’arte di Hegel, restituendo alla bellezza non più un senso visibile ma un valore invisibile: “Il fatto che il dipinto fosse ‘nato dallo spirito’ significava per Hegel che aveva un’importanza che mancava ai fenomeni naturali […] Iniziai a pensare che la bellezza di un’opera d’arte poteva essere interna ad essa, parte del significato dell’opera” (p.35). La bellezza perde dunque le sue qualità estetiche, non ha più nulla a che fare con simmetria, armonia, e quant’altro possa determinare un piacevole godimento da parte del soggetto, mentre si rifugia dentro l’oggetto stesso, divenendo una spettrale incarnazione della realtà, un segreto che solo una filosofia dell’arte è in grado di portare allo scoperto. Per tale motivo, il pensiero di Danto non prende l’avvio dal riconoscimento della grandezza dell’arte, ma solo e soltanto dalla sua fine, di cui la Brillo Box rappresenterebbe una sorta di hegeliano capolinea storico. La rivolta contro la bellezza è compiuta e finalmente l’arte, esalando l’ultimo respiro, può riconoscere in se stessa la qualità metafisica dell’autoriflessione. “La fine dell’arte in Hegel – scrive Danto – quindi non ha niente a che vedere con il declino dell’arte, ma con il fatto che noi non richiediamo più che le idee siano comunicate in forma sensibile” (p.111). L’arte assume su di sé per intero l’onere di manifestare l’invisibile, disincarnarsi per diventare il fantasma di una verità più alta cui essa allude con la sua enigmatica presenza. Essa deve essere “razionale e sensibile allo stesso tempo”. Per il filosofo si tratta di “determinare come le sue proprietà sensibili siano connesse al suo contenuto razionale” (p.112). Senza un contenuto razionale l’orinatoio di Duchamp tornerebbe ad essere un accessorio per esigenze fisiologiche e la Brillo Box di Warhol un semplice e banale contenitore di pagliette per massaie. Resta da chiedersi cosa rimane dell’arte dopo che è stata disincarnata e ridotta al velo di Maya che la filosofia deve solo trovare il coraggio di lacerare. Rimane ancora aperto l’interrogativo: cosa fa di un oggetto di uso comune un’opera d’arte? Non si rischia di confondere tutto con tutto e far cadere proprio quelle distinzioni che il Settecento aveva con fatica creato con il sistema delle belle arti, quando accomunando arte e bellezza aveva tentato di collocare la perizia tutta manuale dell’artista nell’ambito di un sistema di valorizzazione del fare? Cosa rimane all’arte? Dopo la fine dell’arte, l’artista potrebbe porsi la domanda: cosa ci faccio qui se il mio è solo un girare a vuoto? L’epoca post-storica, così la chiama Danto, non rappresenterebbe la fine del fare arte, ma il momento storico in cui finalmente è possibile dare seguito all’interrogativo fondamentale sul senso filosofico dell’arte, giacché proprio la produzione creativa non avrebbe più nulla da proporre e sperimentare, non avrebbe più nulla da dire.
La sottrazione dell’arte al bello dovrebbe significare, secondo Danto, la sua liberazione dal dominio del pensiero filosofico che sconterebbe la colpa di averne imbrigliato il senso dentro a degli schemi rigidi, stabili e immutabili. L’apparente rifiuto della bellezza e dell’estetica sembra essere legata al rifiuto del particolare e del soggettivo, vale a dire del gusto e del piacere estetico. Il piacere del bello, infatti, impedirebbe kantianamente la ricerca di un criterio universale di interpretazione in cui tutte le cose possano essere ricomprese e giustificate (ma non è questa una forma di totalizzazione di ispirazione hegeliana?).
L’arte dovrebbe divenire filosofia, elaborare una sua filosofia dell’arte che parta dal concreto manifestarsi di valori che vadano oltre il punto di vista del godimento estetico soggettivo. A questo punto sorge la domanda: non significa tutto questo porla di nuovo sotto l’egida asfissiante del pensiero filosofico, svuotarla nella specificità e autonomia? Dopo la fine dell’arte non c’è solo la filosofia (nessuno esclude l’importanza della mediazione filosofica), ma continua ad esserci l’arte che chiede di essere finalmente letta come arte, e non più, giustamente, con gli strumenti disciplinari dell’estetica filosofica, ma tornando al senso più estremo attribuibile all’aìsthesis, cioè sentire, percepire, riscoprire l’estetico.
La riflessione di Danto appare molto importante, pur con tutte le riserve che qui molto brevemente sono state esposte, giacché tenta di risolvere un enigma di fronte al quale tutti restiamo attoniti e stupiti: come può una scatola di pagliette diventare un’opera d’arte? Se il progetto è quello di combattere i detrattori dell’arte, coloro i quali ne sostengono l’insignificanza filosofica e il vuoto simbolico, allora non si può che elogiare l’ampio sforzo teorico di rimettere al centro del dibattito la portata di pensiero ed il potere simbolico presente nella creazione artistica.
Pietro Marino / Gazzetta del Mezzogiorno / 4 luglio 2008
Viaggio nell’identità dell’arte
La Bellezza usi e abusi
Ossessioni da Kant a Warhol. Se nel Settecento vigeva il potere dell’Estetica, i secoli successivi hanno messo in dubbio i canoni e le certezze. In un saggio di Arthur Danto la storia della demitizzazione, degli eccessi e l’elogio del Brutto.
Un fantasma si aggira da tempo nel castello dell’Arte, sempre più inquieto e ansioso di recuperare visibilità. E’ il fantasma della Bellezza. Che l’Arte abbia deciso di separarsi da Lei, e l’abbia segregata, e più volte tentato addirittura di sopprimerla, è storia di almeno un secolo. A questa vicenda si riferisce Arthur Danto, l’ultraottantenne filosofo americano, ben noto agli addetti ai lavori, meno al grande pubblico, con un saggio del 2003, ora pubblicato in Italia da una piccola ma coraggiosa casa editrice milanese (L’abuso della bellezza –Da Kant alla Brillo Box, Postmedia books, 192 pagine con illustrazioni b.n. nel testo, 21 euro). Si fa portavoce di quella inquietudine, pur avendo contribuito autorevolmente a certificare il misfatto. Lo ammette senza esitazioni: «Considero la scoperta che si possa fare buona arte senza farla bella uno dei più grandi chiarimenti concettuali della filosofia
dell’arte del XX secolo». Gran parte del saggio è dedicata a spiegare come e perché ciò sia avvenuto. Lo propone «come un racconto di avventure, con qualche argomento filosofico». E però, l’amabilità discorsiva non evita la complessità delle questioni (la traduzione sembra spesso in affanno). Esse infatti chiamano in causa anche la nozione, l’identità dell’Arte: ci troviamo insomma in un calviniano castello dei destini incrociati.
Danto narra «come l’arte intrattabile demitizzò la bellezza». Il tempo felice del matrimonio che sembrava indissolubile fra Arte e Bellezza fu il Settecento, con la nascita dell’Estetica (Baumgarten). Ma la crisi concettuale appare già in Kant, proprio il grande architetto del pensiero classicista. Al Bello egli affianca il Sublime, il mondo preromantico del mistero, del pauroso, del grandioso. Così l’Arte, oltre alla moglie si fa l’amante (molto più eccitante).Di più: il concetto kantiano di Gusto dissolve definitivamente la Bellezza come entità metafisica. I colpi di grazia li dà Hegel. Distingue la bellezza della Natura da quella dell’Arte: e proclama la superiorità della bellezza «artificiale» su quella naturale perché «nata e rinata dallo Spirito». Infatti l’Arte è un gradino della vita dello Spirito, nella scala che porta alla Ragione. Dunque – annota il neohegeliano filosofo - la bellezza dell’arte è «un prodotto intellettuale piuttosto che naturale». Le conseguenze pratiche di questo passaggio sono enormi. Intanto, cade l’illusione (peraltro ostinata) che per fare un’arte «bella» sia necessario, o basti, rappresentare la bellezza della natura.
Ma accade ben di più. La Bellezza, privata del suo certificato di identità, comincia ad essere sentita come un orpello, un inganno. Già nel 1873 Rimbaud trova «amara» la Bellezza e la schiaffeggia. Le liti si faranno sempre più pesanti. L’estetica del Brutto (nata con Rosencranz, allievo di Hegel) percorre e segna tutta l’arte del Novecento e oltre: come disvelamento degli orrori del mondo, che la Bellezza non può più nascondere, truccare, far accettare, nemmeno per consolarci. «La vera arte può essere brutta », conferma Danto, e la «bellezza estetica» può essere «artisticamente sbagliata». Ma nella crisi del rapporto amoroso (direbbe Alberoni) peggio dell’Odio c’è l’Indifferenza. E’ quello che fa Duchamp con i suoi ready- made : l’arte è un processo «anestetico» di conoscenza del mondo, è un modo diverso di vedere le cose che già ci sono. Le conseguenze di quello storico «atto di scelta» (è passato quasi un secolo) si sono manifestate dagli anni Sessanta.
A quel tempo si aggancia l’esperienza in diretta di Danto. E’ ossessionato da un‘opera di evidente derivazione duchampiana: la «Brillo Box» di Warhol. Il maestro della Pop Art presenta nel 1964 degli scatoloni di legno che sono l’esatta replica dei cartoni che contengono spugnette per lucidare marca «Brillo» appunto. La questione cruciale (qui ripresa) che il filosofo si pone è: perché la Brillo Box è «un’opera d’ar te» mentre l’originale di cui è copia esatta è solo un oggetto commerciale?
Prima e fondamentale risposta: Brillo Box è un’opera d’ar te perché «include un significato », elabora quel dippiù di pensiero che la scatola con spugnette non aveva. Ne consegue l’accettazione che «tutto può essere arte» se assume «qualche proprietà semantica», cioè se opera una connessione storicamente significativa tra sé e il mondo. Separare l’arte dalla bellezza e separare la filosofia dell’arte dall’estetica è stata quindi «una buona mossa» sul piano teorico.
Ma ora, «immunizzato» da quelle conquiste e da quei chiarimenti, il nostro può dare ascolto al fantasma segregato. E’ vero: l’arte può (talvolta «deve ») fare a meno della bellezza. Però la bellezza è «una condizione necessaria per la vita così come vorremmo viverla». E’ un bisogno etico, non estetico. Si tratta di ridare alla bellezza «un valore morale». Ma che intende Danto per bellezza? Non è – pre - cisa – quella «esteriore», formale, ma la bellezza «interiore»: quella capace di dare «significato » all’opera. Ma in concreto? Segnala in alcune prove della pittura espressionista-astratta americana (da Motherwell a Newman) la «riscoperta dell’uomo». Propone l’audace sospetto che Warhol possa avere scelto le scatole Brillo perché sedotto inconsciamente dal loro originale design grafico. S’incarta non poco: esprime un problema alto, non una lettura salvifica. Sanziona – sostiene, forzando un po’ la mano, Marco Senaldi in prefazione al libro – «l’impossibilità di un uso ingenuo e spassionato della bellezza e costituisce una delle più chiare testimonianze che a noi contemporanei resta solo la drammatica scelta del suo abuso».
|